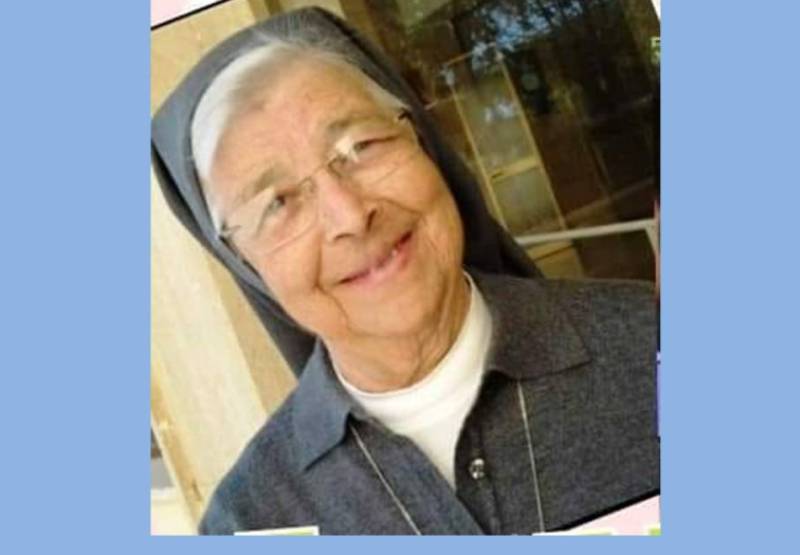Di fronte ad una comunità divisa
Da quanto dice Paolo (1Cor 1,10-12) pare si debba dedurre che il problema a Corinto era stato creato da una eccessiva personalizzazione del messaggio: il settarismo della comunità aveva come motivo la scelta della persona dell’apostolo. A mala pena possiamo avere qualche dato in più riguardo alle circostanze concrete che avevano dato origine a questa situazione in una comunità fondata da Paolo. In ogni caso, è chiaro che la causa del conflitto che stava dividendo la comunità risiedeva in una tendenza al settarismo, personalizzando il vangelo a seconda dell’evangelizzatore preferito. I gruppi sorti a Corinto si distinguevano e si opponevano per la loro visione del cristianesimo secondo il loro favorito predicatore. Non occorre molta immaginazione per individuare a questo punto un pericolo costante nella vita ordinaria del cristiano: la tendenza a scegliere e a seguire modelli di comportamento cristiano, di comprensione della tradizione evangelica più concordi con i bisogni o le attese del gruppo. Dover ricevere l’esperienza di Cristo attraverso l’esperienza che altri hanno fatto di Lui, ci predispone ad accettare Cristo attraverso il vissuto di altri, dell’apostolo che ci ha parlato per primo e che per primo ci ha portato alla fede. Corriamo il pericolo di mediare il nostro incontro personale col Signore Risorto, facendo dell’accompagnatore il maestro, e vangelo dell’evangelizzatore. In seguito, sorge la tendenza alla disgregazione nella comunità cristiana. Una comunità che vuol essere di Cristo può appartenere solo a Lui. Quando si interpone qualcuno tra di essi, sia pure l’apostolo che l’ha fondata, comincia un processo di scomposizione. Il problema non nasce tanto dalla comunità quanto dai suoi apostoli. Chi dedica la sua vita all’evangelizzazione soccombe spesso alla tentazione di legare alla propria persona quanti cerca di legare a Cristo. Raggruppandoli attorno a sé facilmente si illude che li sta riunendo sotto la signoria di Cristo. Amandoli fino al sentimento e sentendosi da essi amato, diviene più sensibile all’amore di Cristo e vengono esclusi da tale amore, con tranquilla coscienza, quanti non ricevono il vangelo come l’abbiamo predicato né si sentono a loro agio con la persona dell’evangelizzatore. Questo “peccato di apostolo” caratterizza, purtroppo, i migliori tra di essi: a Corinto la comunità non elesse degli eresiarchi per dividersi; fu sufficiente dirigersi ai migliori apostoli esistenti in quel momento.
L’unica reazione valida
Quale fu la reazione di Paolo? Il suo atteggiamento è tanto più decisivo in quanto egli stesso era, volente o nolente, uno dei poli della divisione. Nel suo nome si erano raggruppati coloro che non dimenticavano che dovevano a lui l’essere cristiani. Ebbene, risulta sorprendente che lui non fa la minima allusione alla sua condizione di fondatore della comunità; anzi, relativizza il suo operato ricordando loro che non hanno ricevuto la salvezza per mezzo suo. La comunità aveva ricevuto da Paolo solo il vangelo (1Cor 1,14-16). È pure curioso che non respinge direttamente gli argomenti degli altri gruppi: a lui interessa smentire coloro che gli sono più vicini. Di fronte ad una comunità divisa non c’è tempo per sentirsi offeso dal “tradimento” degli altri che non gli rimasero fedeli e nemmeno per evitare l’offesa di coloro che lo avevano scelto come leader.
L’unico motivo legittimo di divisione (1Cor 1,13). Un comportamento così strano ha un suo fondamento. Esiste un solo motivo che giustifichi la rottura della vita comune: solo chi desideri dividere Cristo può osare attentare all’unità della comunità cristiana. Chi fomenta il settarismo della comunità, per quanto cristiani e apostolici possano essere i suoi progetti, sta alimentando la spartizione del suo Signore. Ciò priva senz’altro di motivazione, per quante ragioni si possano addurre, l’alimentatore di discordie, il seminatore di antipatie, colui che vive di dicerie, chi non può perdonare né sa dimenticare. Un apostolo non può prestarsi al gioco della divisione della propria comunità, anche a costo di pagare di persona, anche se ciò significa negare se stesso di fronte alla comunità. L’apostolo, come Paolo, sa bene il motivo. Solo Cristo ha dato la vita, solo Lui è stato crocifisso. Chiedere obbedienza agli uomini, esigere fedeltà o promettere salvezza, può farlo solo colui che è morto ubbidendo e ha pagato con la sua vita la sua fedeltà a Dio. Il vangelo che predica non gli dà nessun diritto di legare a sé coloro a cui deve la libertà che Cristo ha loro ottenuto. La salvezza che amministriamo non l’abbiamo prodotta noi: nessuno è stato battezzato nel nostro nome, a nessuno possiamo assicurare una protezione che non siamo sicuri di possedere neanche per noi stessi. L’apostolo di Cristo si vota corpo e anima per l’unità della sua comunità, perché il suo Signore è morto in croce affinché fosse possibile la nascita di una comunità. È in gioco niente di meno che questo, anche dietro un semplice litigio tra “apostoli” o un semplice contrasto di opinioni nell’ambito della comunità.
Evangelizzare, missione esclusiva (1Cor 1,17). Paolo sa che la sua missione consiste nell’evangelizzare. Non si dedica a nessun’altra attività, poiché Cristo conta su di lui per la proclamazione del vangelo. Può risultarci difficile oggi capire questo primato della predicazione. Al tempo di Paolo si trattava di guadagnare il mondo al vangelo, poiché nessuno poteva essere salvato senza avere ascoltato il messaggio cristiano. Prima di poter sperimentare Cristo e sentirsi salvati, giudei e pagani dovevano conoscere il vangelo ed accettarlo in obbedienza. Solo dopo sorgevano le comunità che celebravano la loro fede comune e condividevano la speranza e l’amore nel contesto del culto. È ora di chiederci a che cosa ci sentiamo realmente chiamati: per chi siamo stati consacrati apostoli? Corriamo il pericolo di perdere la nostra coscienza apostolica proprio perché la diamo per scontata. Apostoli senza coscienza di essere stati inviati non possono seminare altro che discordia e pessimismo. L’inviato non può permettersi di rimanere con niente da fare o con nessuno di coloro a cui è stato destinato. L’apostolo non osa dividere una comunità che gli è stata affidata, di cui non è il padrone. Sapere a Chi dobbiamo la missione ci farà comprendere meglio a chi dobbiamo dedicarci. Avere come missione della nostra vita il vangelo di Cristo ci mette al servizio di quanti lo vogliono ascoltare, senza preferenze né scelte. La scelta non tocca all’eletto; all’inviato non tocca scegliere i prediletti (cfr. Gv 15,16).
La croce come parola apostolica (1Cor 1,18). La sapienza del testimone Dio gliel’ha messa nelle mani e nel cuore, quando gli ha affidato la missione e il vangelo. Per elezione possiede già tutto il sapere necessario per portarla a termine: sapersi inviato. La forza della convinzione non la dà all’apostolo il suo modo di parlare né la sua capacità di ragionare, ma l’oggetto della sua predicazione: la croce di Cristo. Chi può dubitare che il cristianesimo che oggi viviamo sta dimenticando la croce? Qui si può trovare una delle cause – se non l’unica – delle nostre paure nell’evangelizzazione e delle divisioni nella vita comune. La dimenticanza anche se inconscia non per questo è meno colpevole, per cui il nostro vangelo non diventa «parola della croce» (1 Cor 1,18). I messaggi che predichiamo, le parole che diciamo oggi al mondo, più che svelare nascondono il fatto che la salvezza definitiva è stata messa da Dio nella croce di Cristo. La nostra evangelizzazione non è efficace, le nostre attività apostoliche non creano comunità nuove e dividono quelle già esistenti, perché non abbiamo la croce come parola. Gli apostoli attuali preferiscono altri messaggi più consoni colla mentalità odierna. Nelle nostre comunità si tace consapevolmente sul valore salvifico della morte in croce di Cristo. Non è forse vero che presentiamo – forse sarebbe più corretto dire che ‘vendiamo’ – quei messaggi che i nostri destinatari sono disposti ad ascoltare, che riduciamo la sapienza divina a efficacia e strategia umana, che annulliamo il potere di Dio tacendo la parola per la quale sappiamo che Dio si è pronunciato a nostro favore: la croce di Cristo? Dobbiamo riconoscerlo: non siamo convinti della sapienza della croce né della sua onnipotenza. E per questo ci si appiglia ad altre ragioni/motivi e si provvedono altri mezzi. Non parlando della croce o rendendola più “bella”, presentandola più comprensibile o meno esigente, stiamo negando, in pratica, che Dio è stato saggio e potente salvandoci con essa (cfr. 1Cor 1,24-25).
La logica della croce (1Cor 1,19-25). L’apostolo non si accontenta di avere come parola la croce di Cristo (1Cor 1,18). Deve vivere secondo, e sotto, questa stessa “logica”. In fin dei conti può risultare persino facile proclamare la salvezza per tutti, sia pure nella croce di Cristo, se tale croce è sempre quella di un altro e non la propria. Non pagando personalmente, l’apostolo non predica in modo convincente. È qui dove si può trovare una – se non l’unica – radice della nostra inefficacia apostolica. Portiamo un messaggio a cui noi stessi crediamo a malapena, portavoce di una sapienza che non riusciamo ad accettare, mediatori di un potere la cui forza ci è sconosciuta. Da qui, proprio, sorge la frustrazione apostolica: il nostro lavoro non è programmato né messo in pratica con la logica di Dio, con la potenza di Dio, con la croce di Cristo. Ci prepariamo per essere efficienti, ci educhiamo per essere convincenti, rifuggiamo dall’apparire deboli e ci dà fastidio passare per scemi. Con i nostri atteggiamenti stiamo sovvertendo il cuore stesso del vangelo. Cercando il successo apostolico in moneta sonante, stiamo negando che siamo stati salvati per mezzo di un evidente fallimento; inseguendo un sapere che ci aiuti nella nostra missione, spesso ci stiamo allontanando dal saperci già salvati e mandati a salvare. Misurare la bontà di un’azione, comunitaria o personale, in base a criteri di logica umana, attenderci dalla nostra vita o da quella dei nostri destinatari il salario dei nostri sforzi, può costituire un modo di pervertire il vangelo a cui prestiamo la nostra vita e rendiamo inutile e senza senso la vita che abbiamo consacrato al vangelo. Il Dio cristiano è un Dio che supera gli schemi e le attese dei suoi credenti, un Dio che non può essere testimoniato in base al senso comune o prendendo posizioni di forza.