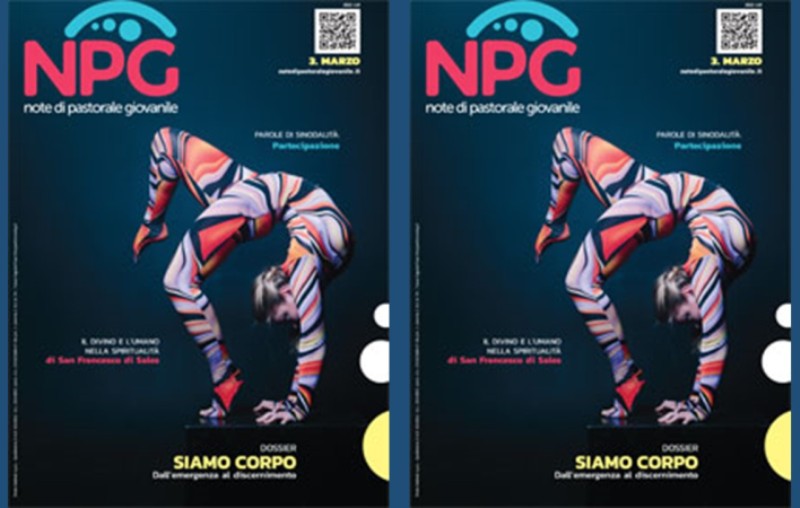Note di Pastorale Giovanile, febbraio 2022 – EDITORIALE al n. 3 del mese di marzo 2022 – Editoriale di Rossano Sala – Un argomento difficile. Parliamo di corpo. È questo l’argomento del Dossier NPG di marzo 2022. Tema ostico, quello del corpo. Significa focalizzarci sull’unicità della nostra persona, non solo dal punto di vista esteriore. Il corpo manifesta lo spessore della nostra singolarità. Noi siamo corpo, appunto. Prima di essere un limite, il corpo è una possibilità. Con il corpo noi siamo nel mondo come oggetti e soprattutto come soggetti.
Come leggeremo nelle pagine seguenti – di cui ringrazio i diversi autori che ci hanno con fatica e soddisfazione messo mano – quella del corpo è una vera emergenza epocale. Propriamente, la condizione attuale dei nostri corpi di carne è la cartina al tornasole di una “questione antropologica” che ha nel corpo una particolare visibilità, tanto da farne un sintomo palese di una “crisi antropologica” in atto da molto tempo.
Ogni sintomo, come sappiamo, rimanda a qualcosa di più importante e radicale: potrebbe essere il segno esteriore di una grave patologia, ma anche un qualcosa che la precede e la manifesta. Se nel primo caso le cose potrebbero mettersi davvero male, nel secondo vediamo nel sintomo una spia provvidenziale, che chiede giusta attenzione e rapida azione.
Attraverso questo Dossier desideriamo pensare alla questione del corpo in questa seconda direzione: lo vediamo come un segnale chiaro per tutti di una rotta che dobbiamo almeno rimettere in discussione.
Non c’è nulla di più interiore dell’esteriorità. Che cosa può dirci un corpo disseminato di piercing e di tatuaggi? O il modo di curare i nostri capelli? O, ancora, il nostro modo di vestire? Oppure che cosa ci dicono le difficoltà alimentari degli adolescenti, che siano l’anoressia per le ragazze e la bulimia per i ragazzi? O alcuni comportamenti estremi che palesemente maltrattano e puniscono il nostro corpo?
Di certo dicono molto rispetto all’anima umana e alla postura spirituale di un ragazzo, di un giovane o di un adulto [1]. Sappiamo che ci sono tanti modi di comunicare, e sicuramente il corpo ha il suo linguaggio che dobbiamo almeno cercare di intuire. Il corpo parla in molti modi. Ultimamente è diventato quasi una tela bianca a completa disposizione del soggetto, su cui ognuno dipinge se stesso per manifestarsi agli altri.
Azzardiamo quindi la tesi per cui la nostra interiorità si fa visibile attraverso il nostro corpo. Il disagio e la fatica, il dolore e l’ansia, la gioia e la felicità si esprimono attraverso di esso, che in genere diventa sempre meno qualcosa da accogliere, accettare e rispettare e sempre più uno spazio espositivo costantemente visibile. Quasi una “mostra permanente”, aperta tutti i giorni dell’anno e a tutte le ore del giorno.
Attraverso il nostro corpo diciamo noi stessi, perché il corpo ha a che fare “interiormente” con la nostra persona. Sappiamo, per esempio, che violare il corpo di un altro attraverso un abuso sessuale significa segnare in profondità la sua interiorità, sfigurare per sempre la sua anima, ferire indelebilmente il suo spirito. Penetrare nel corpo dell’altro significa invadere il suo spazio vitale, entrare in un mondo altro rispetto al proprio, superare quella “distanza di sicurezza” che ha nei confini corporei un limite da valicare solo con sapienza, prudenza e rispetto… e mai con violenza.
La nostra stessa identità è intessuta di alterità. Ma c’è molto di più. Perché il nostro corpo è qualcosa di altro perfino nei confronti di noi stessi. Cioè, siamo il nostro corpo, ma il nostro corpo è un’alterità rispetto a ciò che siamo. Il corpo, direbbe Lacan – psicanalista tanto bizzarro quanto geniale – è segno della nostra originaria “ex-timità”: è insieme intimo a noi e altro da noi. Entrambe le cose, perché nel cuore dell’identità c’è uno spazio per l’alterità.
Paul Ricoeur, un altro francese, ma questa volta filosofo, riconosce tre segnali di quell’alterità che abita la nostra identità e che ci rende drammatica l’esistenza: il corpo, la coscienza e gli altri [2]. Sono i tre richiami inequivocabili di una presenza estranea nel cuore di noi stessi, la manifestazione che siamo abitati da altro, che non esistiamo in solitudine e che invece, addirittura, l’alterità è parte integrante della nostra identità. La nostra identità è intessuta di alterità! E il corpo, che trattiamo talvolta come estraneo (diciamo infatti di “avere” un corpo) e insieme come intimo (sappiamo di “essere” un corpo), ne è un indizio più che evidente.
Quindi, di fronte all’alternativa di affermare se “abbiamo” o “siamo” un corpo, la filosofia dice la giustizia di entrambe le posizioni, che vanno mantenute contemporaneamente: abbiamo un corpo, perché questo sembra essere davvero altro dal nostro “io vivente”, ma allo stesso tempo siamo corpo, perché questo nostro “io” sarebbe inimmaginabile senza il corpo di carne che appunto noi stessi siamo.
Radicalmente chiamati all’esistenza. La questione del corpo è quindi più intrigante e radicale di quanto possa sembrare ad un approccio superficiale. Non è una questione meramente esteriore rispetto alla nostra interiorità, e non è nemmeno qualcosa di estraneo in relazione alla nostra identità. È invece questione intima e identitaria. Quindi siamo chiamati ad andare ad un livello più profondo per comprenderne i dinamismi.
Propriamente andiamo a toccare il livello antropologico e perfino teologico, perché il corpo è prima di tutto il segno permanente della nostra “creaturalità”. Cioè in prima battuta riconosciamo il fatto che non ci siamo fatti da noi stessi, ma siamo stati generati da altri. Che c’era un tempo in cui non c’eravamo e ci sarà un tempo in cui non ci saremo. La nascita e la morte, che riguardano prima di tutto l’inizio e la fine del nostro corpo vivente, ne sono i riferimenti ineludibili.
Proveniamo da altri, non siamo artefici di noi stessi, non siamo i detentori della nostra genesi, non siamo i padroni della nostra esistenza, non ci siamo fatti da noi. E nemmeno coloro che ci hanno dato la vita sono i padroni e i detentori della nostra, per il semplice motivo che i nostri genitori vivono delle nostre stesse condizioni di vita: anche loro, esattamente come noi, sono nati – certamente prima di noi – e anche loro moriranno – prima o dopo di noi.
Siamo stati chiamati all’esistenza, questo è il punto. Proveniamo da altro e siamo destinati ad altro, questa è la verità. Anche se il nostro tempo cerca di convincerci che siamo figli di noi stessi e che il nostro corpo è a nostra completa disposizione, e che possiamo anche coccolare l’idea malsana che potremmo evitare la morte, se andiamo in profondità non possiamo che tacciare questi pensieri come una serie di radicali imposture.
Delirio luciferino, direbbero alcuni teologi. Bisogna allargare gli orizzonti e spalancare la visione, ritornando ad una sana e santa antropologia. Proprio i teologi, di fronte al fatto che Dio ha preso un corpo di carne in Gesù, hanno coniato l’espressione Caro cardo salutis, ovvero che la carne è il cardine della salvezza. Ripartire dalla considerazione della carnalità dell’esistenza può essere quindi un toccasana per questi nostri confusi tempi.
Un’urgente conversione antropologica. Un pensiero serio sul mistero del nostro corpo e quindi del nostro essere non può che condurci verso quella che è bene chiamare “antropologia vocazionale”, e che qualsiasi riflessione – laica e credente che sia – è costretta a riconoscere nel momento in cui vuole essere rispettosa del fenomeno umano della generazione e del corpo, degli affetti e dei legami, della nascita e della morte.
Antropologia vocazionale significa prima di tutto che la nostra esistenza ha a che fare con qualcosa di misterioso. Con “misterioso” vorrei prima di tutto intendere qualcosa che noi non possiamo controllare né orientare né incapsulare, ma che è più grande di noi. Qualcosa che non sta sotto il nostro controllo, né parziale né totale: siamo immersi in una realtà che ci precede, ci accompagna e ci attende. E ci chiede di essere anche interpretata attraverso un discernimento esistenziale. È qualcosa che, comunque la mettiamo, ci trascende da ogni direzione.
Per noi cristiani ciò indica molto di più. Significa riconoscere l’uomo nella sua singolarità assoluta, che trova nel corpo di carne una conferma inequivocabile della sua unicità irripetibile. Quando parliamo di “antropologia vocazionale” infatti proclamiamo la nostra convinzione di fede che ogni persona umana sia stata personalmente desiderata da Dio, sia amata incondizionatamente e definitivamente da lui e sia necessaria ed insostituibile nel suo progetto di salvezza. Più che “avere” una vocazione, ogni essere umano, buono o cattivo, sano o malato, quali che siano le sue qualità o difetti e limiti, e anche le sue colpe, “è” una vocazione, una chiamata. […] Si tratta di un modo di affrontare l’intero mistero dell’essere umano nella sua totalità, come irriducibilmente unito a Dio [3].
L’antropologia vocazionale è l’unico antidoto serio ed efficace ad una cultura impostata a partire da una libertà autoreferenziale del soggetto lasciato a se stesso e irresponsabile verso tutti, in balia della sua autorealizzazione. Va abbandonata la menzogna dell’autofondazione. L’autonomia, pensata in ottica cristiana, non può che essere l’esercizio della responsabilità rispetto ad un dono che ci precede e ci impegna, e che vede nel nostro corpo la sua possibilità di esistenza e di espressione.
Ripartiamo da una “cultura vocazionale”. Purtroppo la parola “vocazione” è una parola assai contaminata. Gode di cattiva fama in diversi ambiti. Ma soprattutto – per colpe tutte nostre, purtroppo – in ambito ecclesiastico. La vocazione, secondo la vulgata, l’avrebbe solo chi ha ricevuto direttamente da Dio una chiamata particolare per un servizio ecclesiastico. Un “reclutamento” di forze speciali per la promozione, il mantenimento e la difesa della Chiesa. Per tutti gli altri uomini e donne questo termine – e quindi questa antropologia e questa cultura “vocazionale” – non avrebbe alcun senso, non li riguarderebbe. Gli altri, appunto, non avrebbero alcuna vocazione, sarebbero delle “esistenze senza chiamata”. Se le cose stessero così la questione vocazionale non sarebbe un “fondamentale” dell’umanità, ma solo una sua sovrastruttura, ovvero una realtà opzionale che riguarderebbe solo alcuni “privilegiati”. Per gli altri – a questo punto una vera “massa dannata” condannata al non senso – varrebbero invece un’antropologia del “fai da te” e una cultura che invita ognuno a orientare la propria vita secondo le voglie del momento. Ora, senza diminuire l’importanza per la Chiesa delle vocazioni “di speciale consacrazione”, è strategico recuperare una cultura vocazionale che riguardi tutti gli uomini e tutte le donne, senza alcuna esclusione. Ripartire da qui nel campo della pastorale giovanile non è più un optional, ma una questione di vita e di morte per la Chiesa stessa. Perché senza questa cultura è impossibile essere aperti al mistero di Dio, è inimmaginabile ascoltare la sua Parola, è impraticabile entrare nello spazio dell’alleanza d’amore con lui. Ripartire dal corpo potrebbe essere strategico. Perché siamo corpo, siamo stati chiamati alla vita, e ogni vita è vocazione. Il corpo di carne è il minimo comune denominatore della vocazionalità dell’esistenza. La sua fragilità è un appello all’amore e alla cura, al reciproco sostegno e alla dedizione gratuita, alla convivialità gioiosa e alla fraternità operosa. Solo così correggeremo il tendenziale neo gnosticismo della nostra epoca che ci relega tutti davanti a uno schermo illudendoci di vivere la vita. E anche vinceremo la tentazione neo pelagiana che oggi seduce molti, convincendoli di essere artefici solitari del loro destino.
NOTE
[1] G. Gillini – M. Zattoni, Il piercing nell’anima. Capire il dolore nascosto dell’adolescente, Àncora, Milano 2005.
[2] P. Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993, 431-474.
[3] S.P. Arnold, Dio è nudo. Inno alla divina fragilità, Queriniana, Brescia, 2021, 82-83.
Da https://notedipastoralegiovanile.it/newsletter/2022/marzo.html